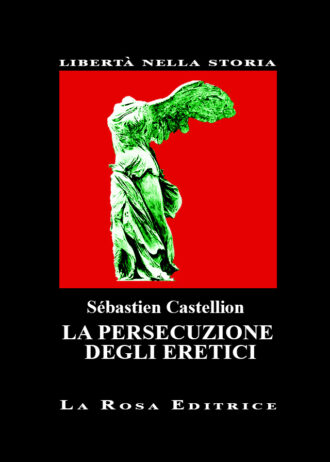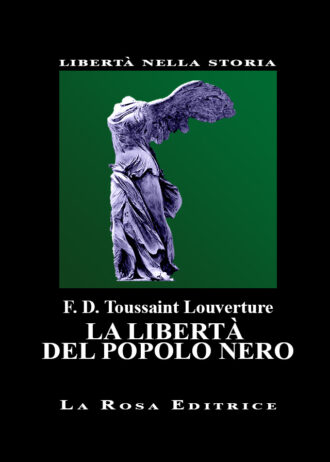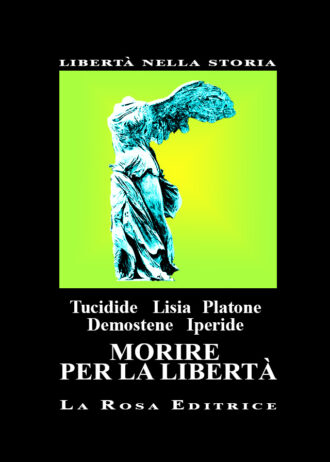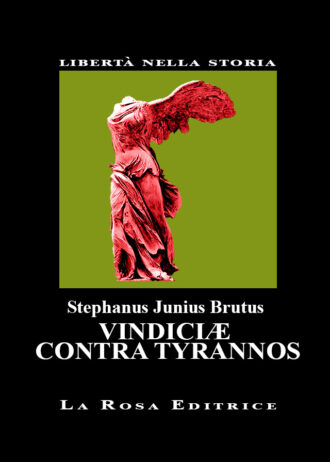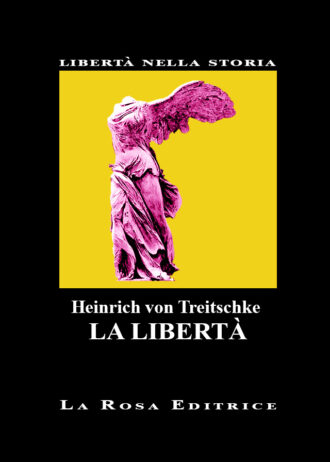Titoli disponibili
LA PERSECUZIONE DEGLI ERETICI
€15,00«Come un moscerino contro un elefante»: è questo il commento che Sébastien Castellion sembra abbia apposto di suo pugno a una copia del De haereticis, an sint persequendi, pubblicato nella primavera del 1554. La metafora è pienamente gistificata, se soltanto si pensa alla sproporzione delle forze in campo: da un lato il grande consenso di cui godeva allora Calvino all’interno del mondo protestante, dall’altro la volontà quasi isolata dell’umanista savoiardo di difendere le conquiste originarie della Riforma, in particolare quella libertà di coscienza che essa aveva opposto all’intolleranza della Chiesa medievale. L’obiettivo polemico del De haereticis è proprio l’apparato ideologico del predicatore ginevrino, il pericolo che esso producesse un assetto istituzionale monolitico e autoritario ancora più gravoso della tirannia romana; il rogo di Serveto, avvenuto in quei mesi, era un terribile segnale in quella direzione.
Ma nello scritto di Castellion vi è molto di più che non la difesa ad oltranza della libertà religiosa: vi opera infatti l’intenzione di ripensare le categorie della fede, in un orizzonte che è certo erede dell’umanesimo erasmiano, ma che raccoglie anche forti suggestioni del misticismo di Sébastien Franck e perfino del pacifismo anabattista. Questi elementi mirano a fondersi in un processo teorico ambizioso, la cui originalità è spesso sottovalutata, nonostante la fortuna dell’opera nelle epoche successive; tuttavia è proprio l’ampio respiro del De haereticis, il suo tentativo di valorizzare l’unicità dell’esperienza religiosa individuale in un orizzonte universale, a farne un testo di fondamentale importanza nella storia moderna della lotta per la libertà di coscienza.
LA LIBERTÀ DEL POPOLO NERO
€15,00Libertà, uguaglianza e fraternità – la triade dei principi rivoluzionari solennemente proclamati a Parigi nel 1789, con i quali inizia la modernità politica – non riguardano la popolazione di colore delle colonie francesi, né l’immenso popolo degli schiavi che in essa vive e soffre. Quegli stessi principi, nondimeno, diventeranno – negli anni tra il 1792 e il 1801 – parole d’ordine per i rivoluzionari neri della colonia francese di Santo Domingo; motivo della loro autonoma mobilitazione in vista dell’abolizione della schiavitù (strappata con l’«immortale decreto» giacobino del 1793); e motore del primo esperimento costituzionale di una Repubblica autonomamente organizzata e governata da cittadini di colore. Toussaint Louverture (1743-1803), nero, ex-schiavo, comandante militare e governatore dell’isola dopo l’abolizione della schiavitù, guidò ed organizzò per intero la transizione rivoluzionaria e contribuì in maniera determinante all’elaborazione della Costituzione. Qui sono raccolti e presentati al lettore italiano – nella prima edizione moderna – i suoi scritti, che testimoniano delle singole fasi della vicenda rivoluzionaria di Santo Domingo ed evidenziano le difficoltà attraverso le quali si concretizza il sogno di liberazione dei «giacobini neri» della colonia francese. La concreta affermazione dell’«assoluto principio» che nessun uomo avrebbe mai più potuto essere proprietà di un suo simile, frutto della rivoluzione di Santo Domingo, sarà, nei decenni successivi, il credo politico degli schiavi dell’intera area caraibica e degli USA, e Toussaint diventerà una figura mitica delle lotte per la libertà del popolo nero.
MORIRE PER LA LIBERTÀ
€14,00EPITAFFI ATENIESI TRA V E IV SEC. A. C.
L’epitaffio è il discorso della città su se stessa, la modalità in cui la classe politica ateniese si è raffigurata come realizzatrice della libertà e della bellezza. Il genere letterario dell’epitaffio, celebrando la superiorità etico-politica di Atene, rappresenta – nella forma dell’elogio di coloro che sono morti per la libertà della polis – l’invenzione stessa dell’immagine di Atene che per secoli si è trasmessa in modo immutabile. Attraverso tutti gli epitaffi superstiti – di Pericle (nella versione di Tucidide), di Lisia, di Platone (il Menesseno), di Demostene e di Iperide – ritradotti e presentati per la prima volta unitariamente, il lettore potrà abbracciare un arco di tempo che va dal 429 al 322 a.C.: la parabola che accompagna Atene dalla guerra del Peloponneso sino alla linea d’ombra dell’egemonia macedone, e che ci consegna l’immagine classica della libertà politica.
VINDICIÆ CONTRA TYRANNOS. IL POTERE LEGITTIMO DEL PRINCIPE SUL POPOLO E DEL POPOLO SUL PRINCIPE
€15,00Le Vindiciæ – pubblicate nel 1579 in latino e nel 1581 in francese, e presentate qui per la prima volta in italiano – sono uno dei testi più emblematici della letteratura politica del periodo delle guerre civili di religione. Nel momento in cui si va delineando con chiarezza l’idea moderna di sovranità, come potere supremo caratterizzante lo Stato, i «monarcomachi» e l’autore delle Vindiciæ (forse Hubert Languet, forse Philippe Duplessis-Mornay) pongono consistenti limiti all’autorità sovrana sulla base di un duplice contratto: tra Dio e re, e tra re e popolo. Mentre l’osservare questo doppio contratto si addice alla dignità regale, il violarlo trasforma i re in tiranni e obbliga il popolo – principio e fine dello Stato e, in ultima istanza, vero sovrano – al rifiuto dell’ubbidienza e, al limite, al tirannicidio. Forte di carica rivoluzionaria, il testo segna un momento cruciale nella tradizione del repubblicanesimo moderno, e si conferma come un classico del pensiero politico della libertà.
INTRODUZIONE ALLA POLITICA
€14,50Con Introduzione alla politica Harold J. Laski, autorevole protagonista della scena inetellettuale di lingua inglese del primo Novecento, guarda con straordinaria lucidità alla crisi della dottrina della sovranità dello Stato, e affronta i temi principali del pluralismo democratico, riaffermando l’associazione come strumento capace di permettere agli individui di esprimere la propria libertà politica e sociale. La riscoperta del pensiero di Laski, cui né il prestigio accademico né il rilievo politico erano valsi ad evitare immeritato oblio, si rivela di sorprendente attualità nell’epoca della globalizzazione. L’autore si oppone alla concezione dello Stato quale unico soggetto della politica un modello di società costituito da più gruppi o centri di potere, non necessariamente in accordo fra loro, ai quali viene demandato il compito di limitare o di contrastare alla concentrazione della sovranità caratteristica dello Stato moderno. Oggi, quando è ormai consumata la dissolvenza di quel venerabile «fantasma» che è stato la dottrina della sovranità, l’insegnamento di Laski può conoscere una nuova vitalità e aprire la strada a auna convivenza libera, pluralista e articolata.
LA LIBERTÀ
€15,00Di grande rilievo dal punto di vista storico, in quanto costituisce un luogo privilegiato per intendere il mutamento degli assetti categoriali e della strategia politica del liberalismo tedesco dopo la sconfitta della rivoluzione del 1848, questo testo giovanile del futuro autore della Politik si presenta altresì ricco di suggestioni teoriche. Muovendo da un serrato confronto con i punti più alti del pensiero politico europeo a lui contemporaneo (in particolare John Stuart Mill), Treitschke giunge a criticare la concezione liberale classica della libertà e la dottrina – sostenuta anche da Wilhelm von Humboldt – che vede nello Stato un male necessario. Ma il luogo centrale del testo, quello in cui più strettamente si connettono interesse storico e suggestioni teoriche, è la rivendicazione polemica della libertà contro l’uguaglianza. Da una parte troviamo qui infatti una chiara formulazione dell’esigenza che il liberalismo del «ceto medio» si differenzi dalle rivendicazioni dell’emergente proletariato; dall’altra, la distinzione concettuale di libertà e uguaglianza impegna Treitschke in una serrata argomentazione (che riprende quella di Tocqueville) sul rischio di una «tirannia dell’opinione pubblica», di una «tirannia sociale della maggioranza».
CONSENSO TACITO
€12,00MODELLI ETICI NEL LIBERALISMO FILOSOFICO AMERICANO
La storia della libertà, il confronto tra le rivoluzioni moderne, l’analisi della democrazia sono i temi su cui riflette lo storico inglese Lord Acton negli scritti qui raccolti, in gran parte inediti in Italia.
Nota introduttiva di Furio Ferraresi