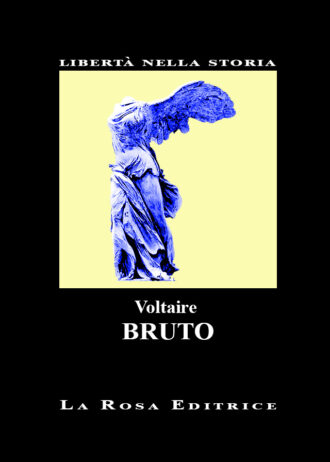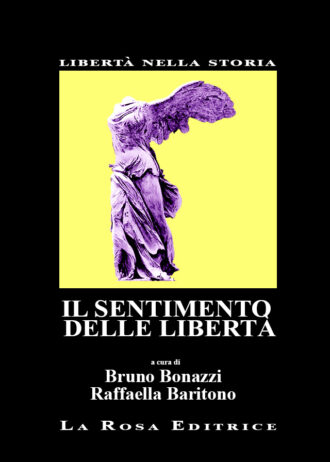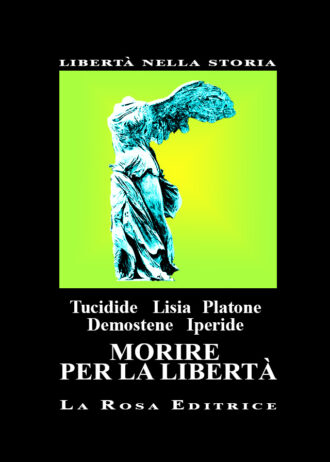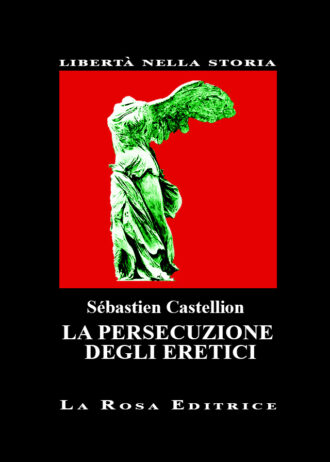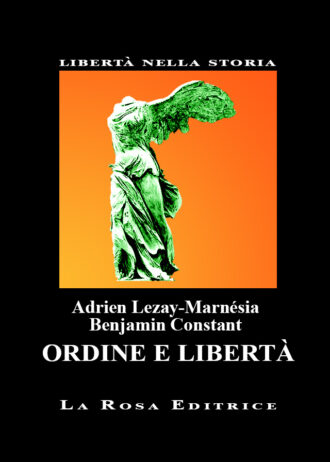Titoli disponibili
BRUTO
€15,00Il Bruto di Voltaire – che qui si presenta per la prima volta in traduzione al lettore italiano – composto nel 1729, portato in scena dalla Comédie Française nel 1730 e pubblicato nel 1731, rappresenta una delle prime prove dell’impegno politico di Voltaire. Bruto è la rappresentazione della lotta tra la libertà repubblicana e la monarchia assoluta, il manifesto dell’elogio della libertà politica del cittadino, valore supremo irrinunciabile, a cui il console Bruto – in lotta contro Tarquinio e Porsenna – sacrificherà anche i propri affetti di padre.
Tappa centrale nella carriera di tragediografo di Voltaire, Bruto è un importante esempio dello studio condotto dall’autore sulla tragedia, che egli vuole innovare accostando alla magnificanza dello stile ereditato dalla tradizione del grande teatro classico di Corneille e Racine lo stile e i contenuti «barbari» del teatro inglese di Shakespeare. Il notevole successo che la tragedia ottenne al proprio apparire in Francia fu dovuto alla valenza rivoluzionaria che il testo conteneva. Bruto segna infatti una delle prime tappe della lotta per la liberà condotta da Voltaire, in qualità di capo del parti philosophique, lungo il XVIII secolo: E proprio in questo senso la tragedia sarà letta dai rivoluzionari francesi, che la trasformeranno in una delle pièces più apprezzate durante la Rivoluzione.
IL SENTIMENTO DELLE LIBERTÀ
€14,00Il sentimento della libertà: era questo ciò che propugnava l’azione e la riflessione delle sostenitrici del movimento dei diritti delle donne negli Stati Uniti della prima metà dell’Ottocento – libertà di parola, di voto, di disporre dei propri beni, di avere la tutela giuridica dei propri figli, di testimoniare in tribunale, per citarne solo alcune. Il modello a cui si richiamava esplicitamente la Dichiarazione dei Sentimenti era la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 1776, a dimostrazione del fatto che le donne facevano appello a quelle stesse «verità di per sé evidenti» che erano state rivendicate dai coloni americani nei confronti di una madrepatria e un re considerati ormai come tiranni. Era a un’altra «tirannia» che si opponevano le donne americane, quella esercitata dall’uomo sulla donna e dal marito sulla moglie, attraverso l’emanazione di leggi cui le donne non avevano dato consenso, o attraverso una lettura errata dei testi sacri. L’estremo interesse dei documenti qui pubblicati risiede proprio nella capacità delle donne americane di appropriarsi del linguaggio e dei concetti politici propri del discorso pubblico americano di quel periodo e di rendere evidenti le contraddizioni e i paradossi di una società che si proclamava democratica; a imperituro ricordo di quanto la questione della cittadinanza femminile sia elemento essenziale ed inscindibile della nascita della modernità e dell’ordine politico occidentale.
MORIRE PER LA LIBERTÀ
€14,00EPITAFFI ATENIESI TRA V E IV SEC. A. C.
L’epitaffio è il discorso della città su se stessa, la modalità in cui la classe politica ateniese si è raffigurata come realizzatrice della libertà e della bellezza. Il genere letterario dell’epitaffio, celebrando la superiorità etico-politica di Atene, rappresenta – nella forma dell’elogio di coloro che sono morti per la libertà della polis – l’invenzione stessa dell’immagine di Atene che per secoli si è trasmessa in modo immutabile. Attraverso tutti gli epitaffi superstiti – di Pericle (nella versione di Tucidide), di Lisia, di Platone (il Menesseno), di Demostene e di Iperide – ritradotti e presentati per la prima volta unitariamente, il lettore potrà abbracciare un arco di tempo che va dal 429 al 322 a.C.: la parabola che accompagna Atene dalla guerra del Peloponneso sino alla linea d’ombra dell’egemonia macedone, e che ci consegna l’immagine classica della libertà politica.
LA PERSECUZIONE DEGLI ERETICI
€15,00«Come un moscerino contro un elefante»: è questo il commento che Sébastien Castellion sembra abbia apposto di suo pugno a una copia del De haereticis, an sint persequendi, pubblicato nella primavera del 1554. La metafora è pienamente gistificata, se soltanto si pensa alla sproporzione delle forze in campo: da un lato il grande consenso di cui godeva allora Calvino all’interno del mondo protestante, dall’altro la volontà quasi isolata dell’umanista savoiardo di difendere le conquiste originarie della Riforma, in particolare quella libertà di coscienza che essa aveva opposto all’intolleranza della Chiesa medievale. L’obiettivo polemico del De haereticis è proprio l’apparato ideologico del predicatore ginevrino, il pericolo che esso producesse un assetto istituzionale monolitico e autoritario ancora più gravoso della tirannia romana; il rogo di Serveto, avvenuto in quei mesi, era un terribile segnale in quella direzione.
Ma nello scritto di Castellion vi è molto di più che non la difesa ad oltranza della libertà religiosa: vi opera infatti l’intenzione di ripensare le categorie della fede, in un orizzonte che è certo erede dell’umanesimo erasmiano, ma che raccoglie anche forti suggestioni del misticismo di Sébastien Franck e perfino del pacifismo anabattista. Questi elementi mirano a fondersi in un processo teorico ambizioso, la cui originalità è spesso sottovalutata, nonostante la fortuna dell’opera nelle epoche successive; tuttavia è proprio l’ampio respiro del De haereticis, il suo tentativo di valorizzare l’unicità dell’esperienza religiosa individuale in un orizzonte universale, a farne un testo di fondamentale importanza nella storia moderna della lotta per la libertà di coscienza.
INTRODUZIONE ALLA POLITICA
€14,50Con Introduzione alla politica Harold J. Laski, autorevole protagonista della scena inetellettuale di lingua inglese del primo Novecento, guarda con straordinaria lucidità alla crisi della dottrina della sovranità dello Stato, e affronta i temi principali del pluralismo democratico, riaffermando l’associazione come strumento capace di permettere agli individui di esprimere la propria libertà politica e sociale. La riscoperta del pensiero di Laski, cui né il prestigio accademico né il rilievo politico erano valsi ad evitare immeritato oblio, si rivela di sorprendente attualità nell’epoca della globalizzazione. L’autore si oppone alla concezione dello Stato quale unico soggetto della politica un modello di società costituito da più gruppi o centri di potere, non necessariamente in accordo fra loro, ai quali viene demandato il compito di limitare o di contrastare alla concentrazione della sovranità caratteristica dello Stato moderno. Oggi, quando è ormai consumata la dissolvenza di quel venerabile «fantasma» che è stato la dottrina della sovranità, l’insegnamento di Laski può conoscere una nuova vitalità e aprire la strada a auna convivenza libera, pluralista e articolata.
ORDINE E LIBERTÀ
€15,00Fra i tanti scritti che, nel periodo direttoriale, s’interrogano sulla Rivoluzione francese e sul nuovo ordine politico da essa introdotto, un posto centrale occupano i due testi – il primo dei quali inedito in Italia – qui pubblicati sotto il titolo Ordine e libertà. In diretta polemica reciproca, il Des causes de la révolution et de ses résultats di Adrien Lezay-Marnésia e il Des effets de la terreur di Benjamin Constant rappresentano le due risposte paradigmatiche alla grande alternativa della politica post-rivoluzionaria: quella, appunto, fra ordine e libertà. Il testo di Lezay – noto agli specialisti, benché mai più ripubblicato dal 1797 – difende le ragioni dell’ordine: ma lo fa ricorrendo ad argomenti di Realpolitik che sfociano in una sorta di giustificazione del Terrore. Il testo di Constant – assai più noto del precedente, benché spesso più citato che letto – difende invece le ragioni della libertà: ma lo fa ricorrendo ad argomenti di principio sulla cui base qualsiasi giustificazione del Terrore diviene impossibile. Si realizza così, tra le posizioni dei due autori, uno scambio esemplare dell’ambiguità connaturata alla politica post-rivoluzionaria: è infatti il moderato Lezay a giustificare la necessità del Terrore, mentre è il progressista Constant a condannarlo senz’appello.
CONSENSO TACITO
€12,00MODELLI ETICI NEL LIBERALISMO FILOSOFICO AMERICANO
La storia della libertà, il confronto tra le rivoluzioni moderne, l’analisi della democrazia sono i temi su cui riflette lo storico inglese Lord Acton negli scritti qui raccolti, in gran parte inediti in Italia.
Nota introduttiva di Furio Ferraresi